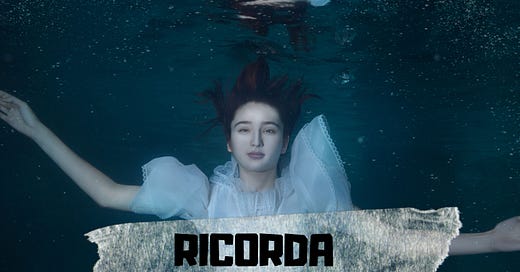Madri e donne assassine
L'ergastolo ad Alessia Pifferi, lo stato crepuscolare di Anna Maria Franzoni e l'arringa dell'avvocato nel caso del Mostro delle Ardenne
L’ergastolo ad Alessia Pifferi
Alessia Pifferi è stata condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal vincolo parentale) della figlia Diana, di 18 mesi.
Pifferi aveva lasciato a casa sola la figlia Diana, nel suo lettino, con alcuni biberon, per andare a casa del compagno. Non era la prima volta che succedeva, ma questa volta era stata via per sei giorni. Al suo rientro a casa, Diana era morta. Erano giorni di grande caldo e i biberon di latte e acqua lasciati alla bambina non sono bastati, è morta per disidratazione. La madre si era limitata ad affermare che credeva che quei biberon bastassero, senza - così è sembrato - porsi il problema che non si può lasciare a casa sola una bambina di 18 mesi, non autosufficiente, in condizioni di totale abbandono morale e materiale.
Fin dalle prime indagini è stato evidente che le condizioni di vita di Alessia Pifferi non fossero comuni ma di totale indigenza e solitudine. Pifferi è nata e cresciuta a Milano; quando aveva sei anni le sue insegnanti hanno consigliato ai genitori di portare la bambina da un neuropsichiatra e che le venisse dato un sostegno in classe. La madre di Pifferi, che non si è mai schierata dalla parte della figlia, durante il processo ha detto: “eeeh, psichiatra psichiatra, la psichiatra è per (gesto del dito a indicare comunemente le persone *matte*), era una psicologa”. Invece Alessia era stata vista da una neuropsichiatra infantile, e tutti erano concordi che avesse dei problemi. Ma erano i primi anni Novanta, un periodo in cui bambine e bambini che non stavano al passo venivano lasciati semplicemente indietro.
Alessia Pifferi dormiva coi suoi genitori e ha usato il ciuccio fino agli undici anni. Arrivata alle superiori, nuovamente gli insegnanti hanno detto ai genitori di fare richiesta di sostegno. Non l’hanno fatto, e quando la madre ha avuto un incidente che le impediva di muoversi l’hanno tolta da scuola perché avevano bisogno di lei. Con la sorella, di nove anni più grande, non c’è mai stato un rapporto. Lo racconta la sorella stessa in tribunale: facevamo due vite completamente separate, non c’è mai stata una relazione.
Alessia Pifferi fa sempre lavori precari: babysitter, badante, donna delle pulizie, assistente alla poltrona. A vent’anni conosce un uomo che ha trent’anni più di lei: scappano in Sicilia, regione di origine di lui, e si sposano. Vanno a vivere dalla madre di lui, sono entrambi disoccupati. Lei resta incinta, ma perde il bambino e quasi ci rimette l’utero, spaventata decide di tornare a Milano. La psicologa dell’ospedale che l’ha in cura manda a chiamare il marito E LA MADRE. È una donna adulta, ormai, ma chiamano anche la madre.
Quando nasce Diana, Pifferi ha una relazione con un uomo - anche lui molto più grande - che vive a Bergamo. La donna partorisce nel bagno di casa di lui, dice che non sapeva di essere incinta, né di chi. L’uomo afferma in tribunale di aver sempre ignorato della gravidanza di lei. Diana nasce in anticipo, e per questo passa un mese in ospedale, a Bergamo. UN MESE. Sua madre ha raccontato di aver partorito in bagno e di non aver fatto nessun esame prenatale perché non sapeva della gravidanza, ma nessuno ha pensato che la situazione fosse da attenzionare. Quando Diana esce dall’ospedale, Alessia torna a vivere a casa sua perché il compagno non vuole la bambina, e arriva sua madre dalla Calabria. Tempo dopo, Alessia e il compagno vanno a fare un weekend e in quell’occasione la bambina si sente male, ha la febbre alta. La nonna la porta a Bergamo, nello stesso ospedale in cui è nata, e non riesce a rintracciare la figlia se non molte ore dopo: anche in questo caso, nessuno si farà domande.
Quando la madre torna in Calabria, Alessia ospita per un periodo una ragazza e poi si fa aiutare da un’amica di infanzia, che però a luglio del 2022 trova lavoro. Alessia Pifferi non resta mai veramente sola con Diana.
Durante il processo, il PM chiede a Pifferi: lei ha mai lavorato da quando è nata Diana?
Lei risponde di no. In realtà è una domanda pretestuosa. Il PM si riferisce al fatto che Alessia Pifferi si è prostituita accogliendo uomini in casa. La donna non aveva lavoro, non poteva trovare lavoro soprattutto perché madre di una bambina piccola, senza un vero supporto, e la madre le inviava 150 euro al mese. Diana è sempre stata ben vestita, nutrita, attiva e perfettamente sviluppata, nonostante fosse nata prematura.
La sorella di Pifferi non ha mai visto Diana. Ma se lei stessa ha ammesso di non aver mai avuto un rapporto con Alessia, perché avrebbe dovuto? Madre e sorella si schierano in ogni modo contro Alessia Pifferi.
La perizia psichiatrica
Il giudice ha disposto una perizia psichiatrica, pur senza prendere in considerazione la storia di Alessia Pifferi. Da quanto è emerso, infatti, i documenti relativi alla salute mentale di Alessia Pifferi non sarebbero stati ammessi al processo. In genere, la perizia psichiatrica si richiede quando ci sono elementi che fanno pensare a un disturbo o patologia pre-esistenti, o per un gesto clamoroso.
Durante la sua detenzione, le psicologhe del carcere (che non erano incaricate della perizia, il perito è incaricato dal Giudice, ma la difesa può richiedere una consulenza e presentarla a supporto) hanno sottoposto la donna a diversi test, che avevano decretato un QI molto basso, come quello di una bambina. I risultati sono stati smentiti dalla perizia disposta dal Giudice e adesso c’è un’indagine in corso sulle psicologhe.
Il perito nominato dal tribunale ha sentenziato che Alessia Pifferi è capace di intendere e di volere e lo era al momento dei fatti. Che poteva essere quindi giudicata regolarmente e che non può avere sconti sulla base di problemi mentali.
L’ergastolo si basa sui fatti e sulla legge, non sulle emozioni
Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo. Questa sentenza è stata accolta pressoché unanimemente con soddisfazione, perché quanto accaduto alla piccola Diana è atroce, orribile, non ci si può nemmeno fermare a pensare perché spezza il cuore. Ma una condanna all’ergastolo non può essere emessa perché così domanda il cuore, ma solo se e quando una persona venga oggettivamente ritenuta colpevole di un reato commesso in piena capacità di intendere e di volere: in questo caso l’omicidio volontario di Diana che sommato alle aggravanti (futili motivi e parentela) ha come pena l’ergastolo. Ma siamo davvero convinti oltre ogni ragionevole dubbio che Alessia Pifferi abbia ucciso la figlia con intenzione e volontà?
L’alternativa non era che Alessia Pifferi non fosse considerata colpevole. Alessia Pifferi È colpevole. Sua figlia è morta per colpa sua. Ma si tratta(va) di stabilire in che modo fosse colpevole. Secondo il PM, a cui la corte ha dato ragione, la donna ha intenzionalmente lasciato a morire sua figlia, fregandosene, cosciente che sarebbe potuta morire.
Fare una riflessione su questa vicenda e sul totale abbandono in cui vertono le madri in Italia e ancora di più le madri in povertà, non istruite e (parrebbe) emotivamente immature, non significa sollevare Alessia Pifferi da ogni colpa. Ma dovrebbe aiutarci a non ripetere errori come questo e a salvare un’altra Diana. Perché l’ospedale non ha attivato nessun percorso per Alessia Pifferi? Perché hanno ritenuto normale non segnalarla ai servizi sociali? Perché la madre e la sorella non l’hanno segnalata, se erano preoccupate? Perché il compagno ha trovato normale che una donna, per sei giorni, non chiedesse mai notizie della figlia che aveva detto essere al mare con la sorella (con cui, ricordiamo, non aveva rapporti)?
Anna Maria Franzoni e il rifiuto della perizia
Come nel caso di Pifferi, quando Samuele Lorenzi è stato trovato morto, nel 2002, il mondo si è diviso a metà: chi non aveva dubbi sulla colpevolezza di Franzoni e chi invece diceva “non è possibile”. Il non è possibile era in minima parte frutto di considerazioni pratiche sullo svolgimento del delitto, ma in grande parte era conseguenza del rifiuto generale di considerare una madre capace di una tale atrocità nei confronti del proprio figlio. Alcune ricerche mostrano che è proprio questo pregiudizio - cioè il fatto che consideriamo una madre incapace di uccidere il figlio - a spingere i giudici a richiedere perizie e a leggerne i risultati in maniera favorevole.
… eppure abbastanza spesso, di fronte al figlicidio materno, si ha la tentazione di attribuirlo a tutti i costi alla malattia di mente. Persino il magistrato appare non di rado guidato da questa convinzione: “nella nostra esperienza, anche se nel singolo caso non vi sono precedenti psichiatrici di rilievo o chiari segni di alterazioni psichiche al momento del fatto, il ricorso alla perizia psichiatrica è tappa pressoché obbligata. Solo la patologia psichiatrica riesce infatti a giustificare, a rendere derivabile e comprensibile un delitto che richiede, per la sua esecuzione, lo stravolgimento di uno degli istinti fondamentali, quello materno.”
Neonaticidio e infantcidio materno, Isabella Merzagora e Alessandra Rancati
Per quanto i test possano essere oggettivi, i colloqui e l’interpretazione più generale sono comunque il risultato delle conoscenze e delle esperienze del perito. Non è un’analisi che dà risultato positivo o negativo. Le donne che compiono infanticidio vengono sottoposte a perizia e queste perizie sono nella maggior parte favorevoli, almeno al fine di ottenere uno sconto di pena.
Anna Maria Franzoni si è sempre dichiarata innocente e in appello ha rifiutato la perizia. Ha sempre sostenuto di ricordare tutto e di non avere nessun problema mentale. Nonostante questo, il tribunale ha preteso che venisse stilata una sorta di perizia a partire da tutto il materiale a disposizione dall’inizio delle indagini: interviste, colloqui, altri test, pure le apparizioni di Franzoni in tv. Dopodiché, hanno decretato che la donna avesse agito in preda a uno stato crepuscolare, cioè un restringimento del campo di coscienza che porta a rimuovere totalmente quanto accaduto. Inoltre, le è stato diagnosticato un forte stato ansioso e si è ipotizzata una depressione post parto. Questo ha ridotto la condanna che in primo grado era stata di trent’anni (con rito abbreviato, la condanna in realtà era l’ergastolo) a 16 anni.
La vicenda di Franzoni è molto particolare proprio perché lei ha continuato a dichiararsi innocente. Essere donna e madre l’ha sottoposta a un doppio standard che è centrale nella storia di tutte le donne. Messa alla gogna da chiunque, ma graziata dalla giustizia stessa che sembra non poter credere che sia stata capace di accoltellare il figlio in maniera così violenta. In entrambi i casi, non è Franzoni in sé, ma il fatto che sia, appunto, una madre.
Ma se Franzoni è colpevole, come dimostrano le gocce di sangue sul suo pigiama, e se ha agito senza poi ricordare, possiamo andare oltre e pensare ancora una volta alla solitudine delle madri. La colpevole resta lei, ma forse è il caso di cominciare a occuparsi della salute (fisica, mentale) delle madri.
Ma lei è una donna, è una madre
Sono queste le parole usate più spesso per parlare di Monique Olivier, moglie del cosiddetto Mostro delle Ardenne, cioè Michel Fourniret. Fourniret ha abusato di numerose bambine e ragazze, che poi ha ucciso e fatto sparire. Nonostante le sparizioni fossero tutte in un’area circoscritta, la polizia francese e quella belga (operava al confine) non hanno capito niente finché una bambina non è riuscita a scappare dal furgone con cui la stava rapendo e a chiedere aiuto a un passante, che poi ha preso il numero di targa dell’uomo. Lui non ha mai ammesso nulla finché la moglie, mesi dopo, non ha parlato e fatto i nomi delle bambine/ragazze rapite e uccise. Dopo altro tempo, ha ammesso di aver collaborato col marito.
Olivier ha avuto un ruolo centrale nei crimini. Avvicinava le ragazzine, spesso col bambino che avevano avuto insieme nel 1988. Se necessario, si occupava di loro in casa (quando Fourniret, per non destare sospetti, tornava a lavorare rimandando abusi e delitto). Secondo alcune ricostruzioni le ispezionava sessualmente per assicurarsi che fossero vergini, o comunque effettuava loro una “toilette intima”.
Marito e moglie hanno avuto processi diversi. Per tutto il tempo, si è sottolineato che Monique Olivier fosse donna e madre. Lo faceva il PM, ma anche la stampa, le famiglie delle vittime, la gente comune. Come può una donna, una madre, fare una cosa del genere?
Nella sua arringa finale, l’avvocato difensore di Olivier dice: continuate a dire che lei è donna e madre, ma perché nessuno ha mai detto di Fourniret, che sceglieva bambine sempre più piccole perché “doveva prendersi la loro verginità”, che è un uomo e un padre?
È una bella domanda, ed è quella che accomuna tutte le storie di donne (e madri) criminali. La loro colpa è più colpa, anche quando hanno fatto meno, perché sono donne e madri. O anche: è impossibile capire come una donna e madre possa aver commesso certi crimini, anche in tribunale.
È bene ricordare che pedofilia e incesto sono crimini commessi in (grandissima) prevalenza dagli uomini, che spesso sono padri. Padri che stuprano le proprie figlie o nipoti. È bene ricordare che quasi il 70% dei figlicidi in Italia è commesso dai padri (dati EURES), e che le madri che uccidono commettono in prevalenza neonaticidio. Che sì, forse tenderemo anche in tribunale a cercare una spiegazione, ma non si può prescindere dai dati: perché le madri uccidono i neonati e i padri sterminano famiglie? Sarà che alla violenza maschile ci siamo abituate e abituati da secoli, che ci sembra cosa normale? Che un padre sia un serial killer, un pedofilo, un abuser, un femminicida, un infanticida, un genocida, è normale e questo non ci sconvolge, mentre quando lo fa una donna, che rappresenta una piccolissima percentuale di chi commette crimini, ci stupiamo?
Giustificare le madri?
Perché quindi abbiamo messo insieme Alessia Pifferi, Anna Maria Franzoni e Monique Olivier? Perché tutte e tre, con modalità diverse, sono state sottoposte al doppio standard dell’essere donne e madri. Uno doppio standard che non viene mai considerato quando a compiere il crimine è un uomo. Nessuno, né la gente comune, né i media, né i tribunali, si soffermano sul fatto che il colpevole in questione sia anche un padre, o un nonno. Un uomo viene giudicato per il crimine che ha commesso.
Lo status di madre, invece, influenza ogni ambito, da quello della cronaca a quello processuale. E lo fa assumendo forme diverse: c’è chi crede che la donna in questione sia ancora più colpevole perché madre; c’è chi pensa che non possa aver fatto niente perché è madre; c’è chi tende a trovare delle attenuanti tramite lo stato di salute mentale perché madre. Il fatto di essere madre può quindi diventare un’aggravante, come per Alessia Pifferi e Monique Olivier, oppure un’attenuante, come per Anna Maria Franzoni, sottoposta contro la sua volontà a perizia psichiatrica.
Quello che è certo è che queste storie raccontano, tutte, così come i femminicidi, una verità. Le donne sono spesso invisibili. Lo sono quando vanno a denunciare uno stalker e non vengono ascoltate. Lo sono quando vogliono separarsi e nessuno le supporta. Lo sono quando cercano lavoro ma coi bambini piccoli non lo trovano. Lo sono quando vivono in stato depressivo e nessuno se ne rende conto. La verità è che se qualcuno le avesse viste, queste donne, se qualcuno si fosse reso conto del pericolo che loro o chi intorno a loro correva, oggi si conterebbero meno morti.
Chi siamo
Anna Bardazzi è nata a Prato e dopo più di dieci anni all’estero oggi vive a Milano. È autrice e copy writer e ha pubblicato il romanzo La felicità non va interrotta (Salani).
Roberta Sandri è avvocata con studio a Trento, si occupa principalmente di diritto di famiglia, dei minori e della persona, svolgendo anche la funzione di curatore speciale del minore e coordinatore genitoriale. Ha una specializzazione in Scienze Criminali ottenuta presso l’Università Montesquieu di Bordeaux.